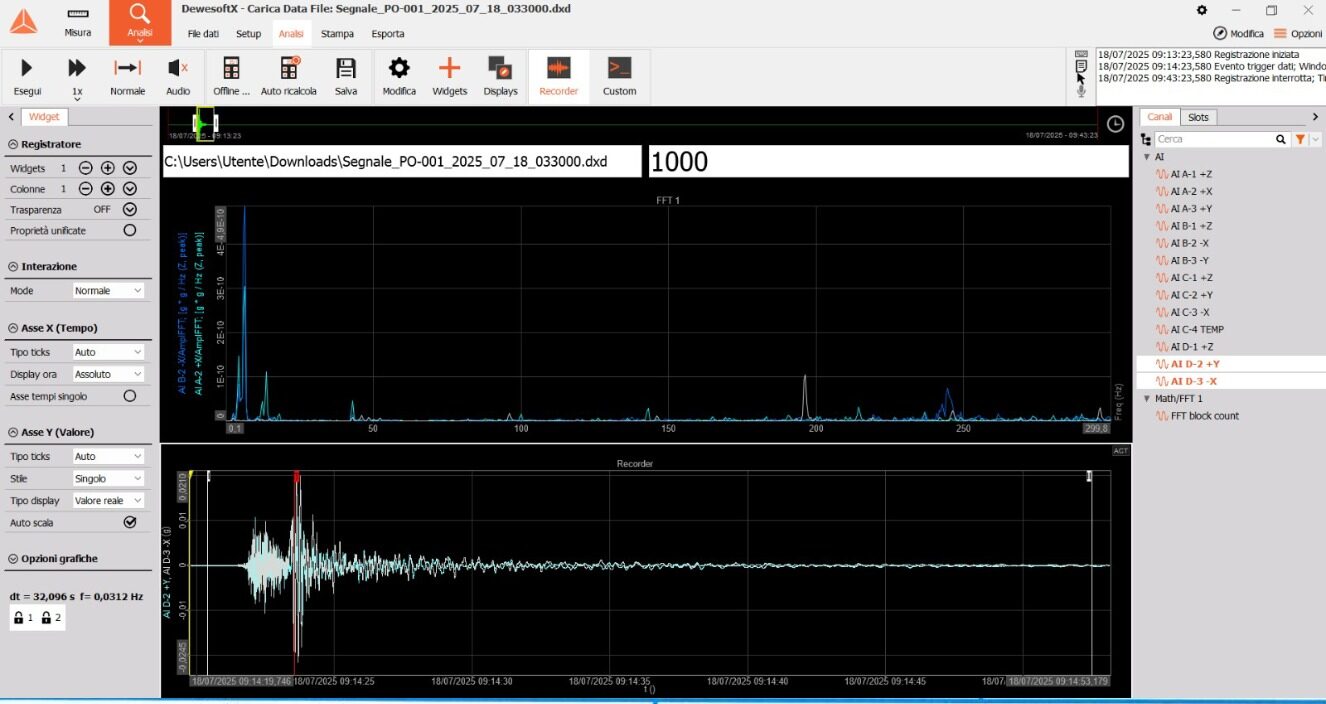“Alè alè alè alè Diego Diego”: con Maradona al San Paolo era festa ogni domenica

 Le scale erano enormi per me, un ciclopico ammasso di cemento e stai attento a dove metti i piedi. Puzzo di piscio e timore della calca che accorreva veloce. Non capivo mai se fosse presto o tardi ma la mia mano, a volte il braccio, lo stringeva mio padre guidandomi tra la folla gradino dopo gradino; e mi guardava ogni tanto, percepiva le mie emozioni. Io guardavo in alto, a tutti quei piedi che mi precedevano. Marciavano quasi all’unisono; salendo e assecondando nel mio immaginario il tam tam dei tamburi che una volta entrati, diventava un sottofondo, un richiamo, la consapevolezza per me di essere in quelle domeniche, nel posto migliore possibile. Il volume aumentava ad ogni passo come se le gambe muovessero una levetta di uno stereo potente, anche se a me tremavano, tremavano sempre. Poi però quel “Gainsboro” si apriva contrapponendosi al celeste vivido del cielo e subito gli occhi giù al rettangolo verde di gioco e allora mi univo al coro che poco prima seguivo a mente “alè alè alè alè Diego Diego”.
Le scale erano enormi per me, un ciclopico ammasso di cemento e stai attento a dove metti i piedi. Puzzo di piscio e timore della calca che accorreva veloce. Non capivo mai se fosse presto o tardi ma la mia mano, a volte il braccio, lo stringeva mio padre guidandomi tra la folla gradino dopo gradino; e mi guardava ogni tanto, percepiva le mie emozioni. Io guardavo in alto, a tutti quei piedi che mi precedevano. Marciavano quasi all’unisono; salendo e assecondando nel mio immaginario il tam tam dei tamburi che una volta entrati, diventava un sottofondo, un richiamo, la consapevolezza per me di essere in quelle domeniche, nel posto migliore possibile. Il volume aumentava ad ogni passo come se le gambe muovessero una levetta di uno stereo potente, anche se a me tremavano, tremavano sempre. Poi però quel “Gainsboro” si apriva contrapponendosi al celeste vivido del cielo e subito gli occhi giù al rettangolo verde di gioco e allora mi univo al coro che poco prima seguivo a mente “alè alè alè alè Diego Diego”.
 Iniziavo a scrutare la gradinata; passavo in rassegna i sediolini in plastica che il sole e le infinite sedute avevano graffiato portando il rosso originale ad un seducente e popolare rosa salmone. Bisognava cercare posto e a differenza di mio padre che avrebbe visto la partita anche in bilico su un corrimano, io odiavo stare in piedi. Lui invece guardava ancora il campo, cercava con gli occhi il numero dieci in maglia azzurra tra i tanti che occupavano il campo durante il riscaldamento. Lo guardava come un uomo guarda la sua donna ballare: quando la desidera, quando ne è innamorato, quando quella sottile invidia e insicurezza si fondono con l’orgoglio e la consapevolezza di averla con sé. Poi distoglieva lo sguardo e quasi rinsavendo senza parlare ma più eloquente che mai, verso di me inarcava le sopracciglia mostrando tutta la meraviglia e la passione riflessa in quegli occhi verdi.
Iniziavo a scrutare la gradinata; passavo in rassegna i sediolini in plastica che il sole e le infinite sedute avevano graffiato portando il rosso originale ad un seducente e popolare rosa salmone. Bisognava cercare posto e a differenza di mio padre che avrebbe visto la partita anche in bilico su un corrimano, io odiavo stare in piedi. Lui invece guardava ancora il campo, cercava con gli occhi il numero dieci in maglia azzurra tra i tanti che occupavano il campo durante il riscaldamento. Lo guardava come un uomo guarda la sua donna ballare: quando la desidera, quando ne è innamorato, quando quella sottile invidia e insicurezza si fondono con l’orgoglio e la consapevolezza di averla con sé. Poi distoglieva lo sguardo e quasi rinsavendo senza parlare ma più eloquente che mai, verso di me inarcava le sopracciglia mostrando tutta la meraviglia e la passione riflessa in quegli occhi verdi.
“Borghetti, Cornetti chi beve, coca cola jamme co borghetto jamme co borghetto gelatiii. I CHE NAPULE”. Il venditore ambulante cercava di passare tra gli spettatori con al braccio il suo secchio ricolmo di vivande e di coprire con le sue grida, i cori incessanti della tifoseria. La mia presunzione infantile mi impediva di chiedere cosa diavolo fosse un “borghetto”, però il diminutivo proposto in maniera così virile e presuntuosa mi risultava piacevole. Il nostro settore comunque era quasi sempre la curva A, talvolta i distinti. In campo, in quel pomeriggio di Gennaio, a sfidare il Napoli c’erano le maglie bianconere del Cesena. Non saprei ricordare nessun calciatore tra le fila Emiliane; ad essere onesti non ne conoscevo nessuno neanche allora. Nessuno tranne Massimo Agostini che si ostinava a presentarsi tra le bustine aperte dei calciatori. A metà di un primo tempo animato soltanto dalle mie aspettative, ricordo che Maradona fu servito sulla trequarti e tenne palla resistendo alla pressione avversaria per un tempo che a me parve interminabile.
Non avevo idea di cosa vedessero di così cattivo i difensori in quelle movenze argentine, ma il mio pensiero era che se avessi preso anche solo la metà di quei calci o anche uno di quei pestoni alle caviglie, probabilmente la mia deambulazione sarebbe stata compromessa per sempre. Quando l’aveva LUI tra i piedi, gli avversari la palla non la toccavano mai e si arrangiavano come potevano; dove essere per loro come guardare la Gioconda da lontano e comprare un souvenir da portare a casa per raccontare di averla vista. Per me invece era come essere al circo. Non sapevo mai cosa volesse o potesse fare; così come non pensavo che potesse d’improvviso lanciare Crippa sulla corsa aprendogli un’autostrada tra la difesa bianconera e permettergli di piazzare il pallone all’angolino.
Napoli in vantaggio, tutti in piedi. Il cielo mi fu oscurato dalle braccia che si cercavano come in Chiesa quando il prete sanciva il celebre e simpatico “scambiatevi un segno di pace”; stavolta però spontaneo e felice. Non credo che mio padre si rendesse conto del dolore che può sentire un bambino di sette anni lanciato contro masse corpulente e festanti, tra buste di cipster e fogli di alluminio che poco prima raccoglievano panini farciti con ingredienti che avrebbero di certo alleggerito se non risolto problemi come “la fame nel mondo”. Il Napoli comunque vinse con quel goal di Crippa appunto 1-0, e volti sorridenti, compreso il mio (al netto di qualche costola malmessa), accompagnavano l’uscita delle persone dallo stadio. “Maradona è na poesia che acconcia a dummeneca” diceva qualcuno. Non voglio però discutere del campione; avevo necessità di giustificare le mie lacrime confondendole con un ricordo, tra i mille che ne seguirono. Certe vite passano veloci senza fare rumore. Altre invece si soffermano tra le speranze e i sogni che frequentano e che fecondano. Ed io oggi ho esultato al goal di Crippa guardando mio padre ridere così come sa fare.