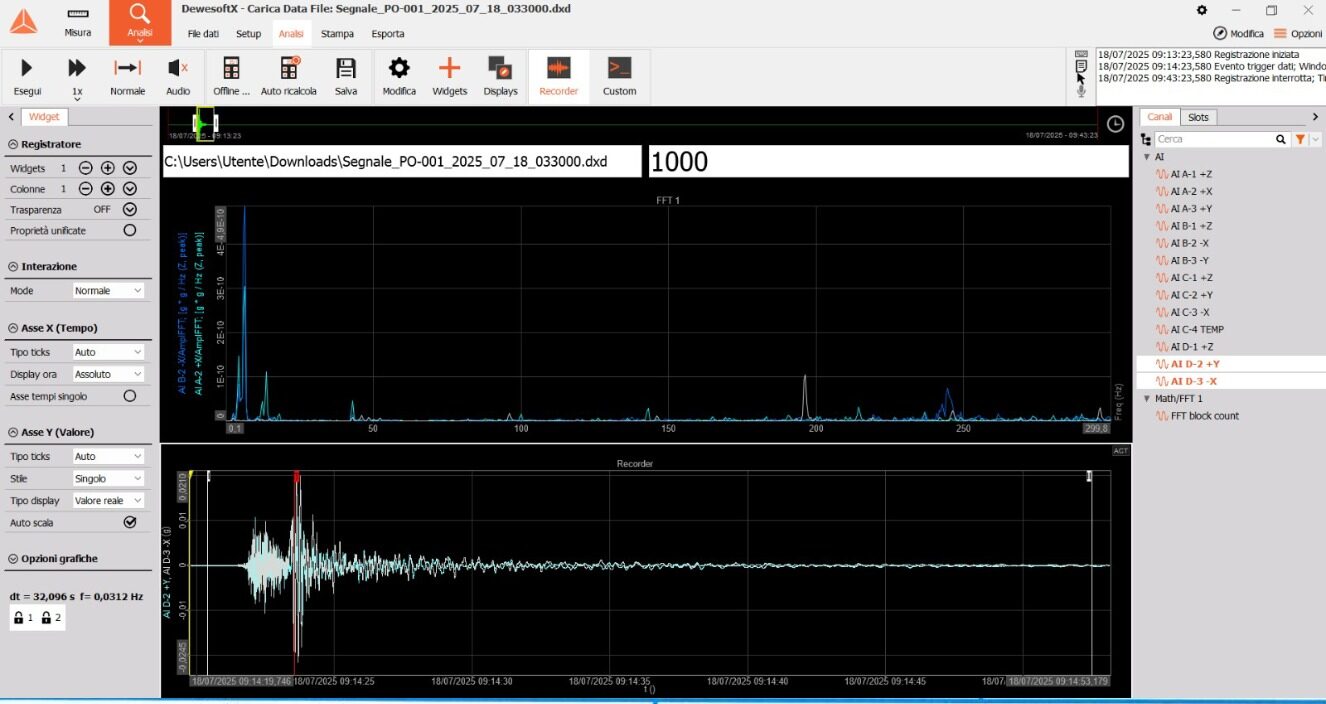La pièce «TERRA»: alla scoperta della lingua puteolana tra tradizioni e parole dimenticate

 BAIA – «È stato un grande linguista francese, de Saussure, a stabilire la differenza tra langue e parole. La langue è la lingua ricevuta (ereditata) dalla tradizione, con tutti i sensi che porta con sé, di cui possiamo essere consapevoli o inconsapevoli. La parole è invece la parola che noi pronunciamo, la parola del parlante, che arricchisce continuamente la langue di sensi nuovi.» Le righe dello scrittore Raffaele La Capria risuonano in maniera prorompente, e ci fanno capire delle caratteristiche fondamentali, per apprendere a grandi linee i principi base della linguistica generale. La parola diventa un groviglio di commistioni e sentimenti, che nutrono la langue giornalmente di simbolismi e accezioni, che fino ad allora non avevano avuto nascita e luogo. L’idioma dialettale è una segmentazione peculiare di un’identità linguista generica, ed è, sovente, la parte più intrigante e distintiva di un popolo. È proprio il dialetto puteolano il perno cardine di un’istallazione teatrale, molto singolare, rappresentata presso il Castello di Baia – Museo Archeologico dei Campi Flegrei, nell’ambito della rassegna Napoli Teatro Festival Italia 2019, diretta da Ruggero Cappuccio.
BAIA – «È stato un grande linguista francese, de Saussure, a stabilire la differenza tra langue e parole. La langue è la lingua ricevuta (ereditata) dalla tradizione, con tutti i sensi che porta con sé, di cui possiamo essere consapevoli o inconsapevoli. La parole è invece la parola che noi pronunciamo, la parola del parlante, che arricchisce continuamente la langue di sensi nuovi.» Le righe dello scrittore Raffaele La Capria risuonano in maniera prorompente, e ci fanno capire delle caratteristiche fondamentali, per apprendere a grandi linee i principi base della linguistica generale. La parola diventa un groviglio di commistioni e sentimenti, che nutrono la langue giornalmente di simbolismi e accezioni, che fino ad allora non avevano avuto nascita e luogo. L’idioma dialettale è una segmentazione peculiare di un’identità linguista generica, ed è, sovente, la parte più intrigante e distintiva di un popolo. È proprio il dialetto puteolano il perno cardine di un’istallazione teatrale, molto singolare, rappresentata presso il Castello di Baia – Museo Archeologico dei Campi Flegrei, nell’ambito della rassegna Napoli Teatro Festival Italia 2019, diretta da Ruggero Cappuccio.
LE TRADIZIONI – La pièce «TERRA» ha la regia e testo di Pako Ioffredo ed è un lavoro profondo e ricercato incentrato sulle tradizioni e il folklore dell’identità puteolana. La scenografia è minimalista, sebbene curata nei dettagli. Il ceppo d’albero posto al centro del palco ricorda la Signora Ceppo (Log Lady) della serie tv I segreti di Twin Peaks idea geniale del regista David Lynch. Sezionato il ceppo, ci sono gli anelli, ognuno di questi rappresentano gli anni dell’albero. Ogni ceppo, quindi, è metafora del tempo trascorso, icona di natura, e radici di un momento storico. Sulla parete frontale è stata creata una proiezione artistica mostrante un mosaico fotografico di ritratti scattati dall’artista Paolo Visone. Lo stile bianco e nero ricorda tanto la posa simile a quella adottata – per anni – dal fotografo americano Richard Avedon. I volti mostrati sono quelli degli abitanti del Rione Terra. Nei due lati estremi del palco: a sinistra è stata disposta una vela triangolare su cui venivano proiettati varie immagine pelagiche tipiche di Pozzuoli, mentre a destra sono stati disposti il bravissimo percussionista-cantautore (Pino Ruffo) e il talentuoso violinista etnico (Alfredo Pumilia).
IL CAST FLEGREO – Il progetto è curato da Cantiere Teatrale Flegreo – EnArt, prodotto da Centro delle Arti della Scena e dell’Audiovisivo (C.A.S.A.), in coproduzione con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei; un ringraziamento speciale va anche alle RAI TECHE, per la concessione del materiale di scena. Il cast è variegato ed è formato da numerosi professionisti: Giuseppe Brunetti, Mario Cangiano, Pako Ioffredo, Demi Licata, Marco Sgamato; le installazioni audiovisive: Mauro Di Rosa; allestimento fotografico: Paolo Visone; musiche originali: Giuseppe Brunetti, Alfredo Pumilia, Pino Ruffo; aiuto regia: Irene Grasso; luci: Alessandro Messina; costumi: Tonia Rendina; collaborazione artistica: Ludovica Tinghi; produzione esecutiva: Roberto Roberto.
IL RIONE TERRA – L’Antica Rocca di Pozzuoli viene narrata in ogni colore, esodo e timori. La lingua puteolana diventa una creatura, ricca di sfumature inconsce ed esistenziali. Nel linguaggio – diceva Lacan – risiede l’inconscio, poiché non c’è nessun elemento più istintivo ed incontrollato nella sfera umana. Nel testo, le parole sono logiche, sentimentali, a tratti complesse, e di difficile comprensione. La decifrazione della semiotica – nei suoi significanti e non significati – diventa un processo arduo ed avvincente per gli spettatori. Il campo della parola irradia le storie dei protagonisti narrati in un flusso episodico. Avvincente l’«Esilio in Prologo: U’Pennone», ove i capitani coraggiosi affrontano la faticosa sfida nata dalle tradizioni folkloristiche dei Campi Flegrei. Ironici e grotteschi i quadri teatrali dedicati al volgo collettivo, pieno di sacralità, fede, e superstizioni. L’arte materica delle superstizioni viene raccontata nella sua oscura bellezza mista tra puteolanità e oblio. Il testo teatrale è ricco di riferimenti orientati verso il sacro; vengono, infatti, declamati famosi incisi religiosi tipici del Nuovo Testamento. Gli emarginati prendono esistenza dopo l’esodo del ’70, e raccontano la loro visione della vita. Il rituale apotropaico della madre (Demi Licata) che sacrifica la sua «mostruosa» figlia, per annientare la maledizione sul Rione, è uno dei quadri empaticamente più teneri del testo ed interpretazione teatrale, poiché ogni atto abbandonico è frutto di solitudine e nostalgia. Complimenti alla giovane compagnia, sperando che tale pièce possa essere ambasciatrice all’estero di un èpos traboccante di elementi iconografici e ricchi di memoria storica.